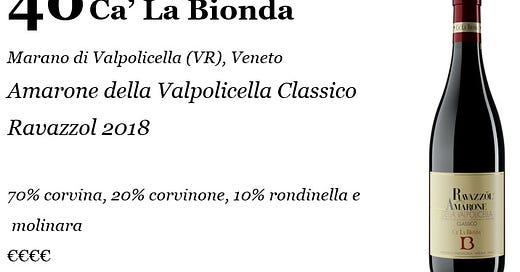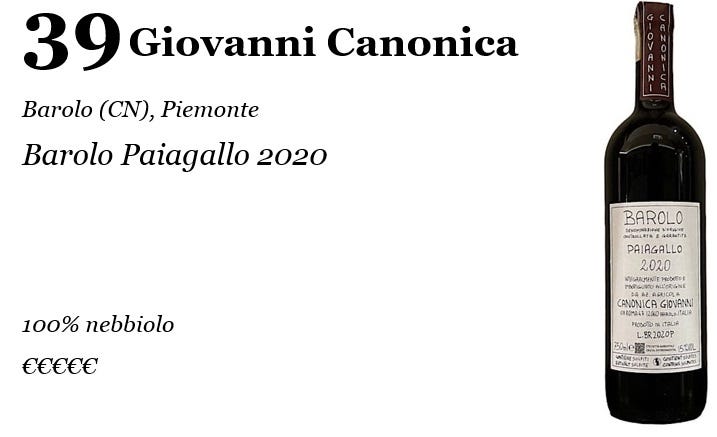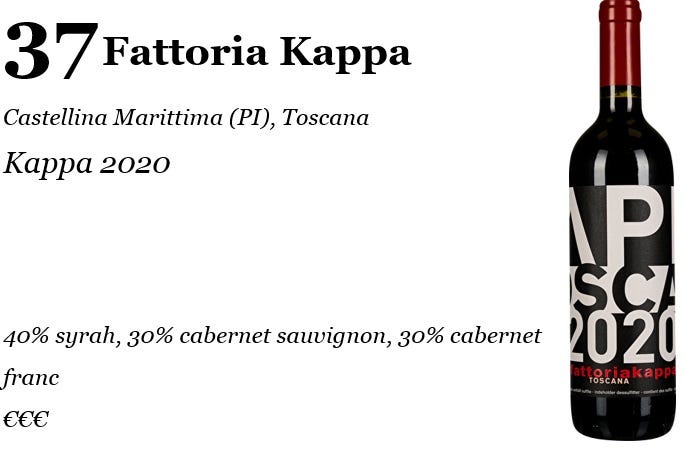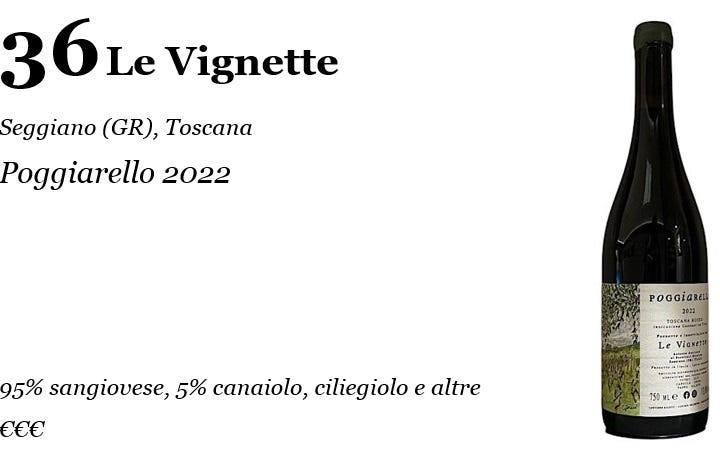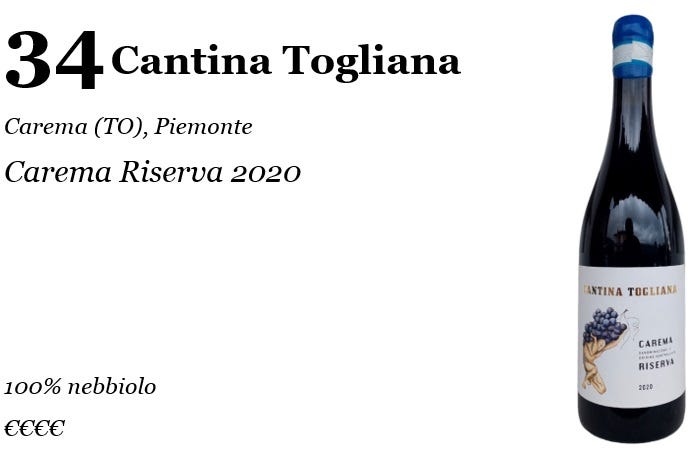Eccoci qua per il secondo appuntamento con la mia classifica dei 50 migliori vini del 2024. A proposito: grazie per avere letto e condiviso la prima parte con i numeri che ho visto!
A scanso di equivoci, ripubblico LA NECESSARIA NOTA METODOLOGICA
Non più di un vino per azienda; solo vini assaggiati in bottiglia per la prima volta durante il 2024; solo vini usciti durante il 2024; solo vini di cui non sia uscita un’annata successiva durante il 2024. I simboli dell’Euro (da uno a cinque) danno un’idea della fascia di prezzo.
Mentre le risposte alle domande ovvie le trovate nella prima parte, assieme alle posizioni dalla 50 alla 41.
Ma andiamo subito a vedere le prossime dieci posizioni:
Altra azienda di cui si discute sempre, tra addetti ai lavori, quando si parla della Valpolicella, dei suoi modelli stilistici, della sua evoluzione. Il lavoro è impostato nel solco della classicità, ma con una grande attenzione a come sono cambiati il clima e il gusto contemporaneo; un Amarone che gioca più sulla complessità, sull’equilibrio, sulla gastronomicità che sulla mera concentrazione. Minerale e balsamico, serioso, grande personalità, bella freschezza, tannino e legno gestiti in modo mirabile: metterà d’accordo anche non pochi detrattori della tipologia.
E qui andiamo necessariamente a citare un monumento, oltre che un vino estremamente ricercato da tutti i nebbiolisti. Nell’annata 2020, il Paiagallo di Canonica è un Barolo già aperto e leggibile, certamente materico, con un fruttone pieno e profondo, super balsamico, con già una bella complessità di note terrose, tartufate, di cuoio, sottobosco, rosa appassita e tutto quello che ci si aspetterebbe da un Barolo di razza con qualche anno in più sulle spalle. Nonostante l’alcool sia importante e si senta (soprattutto quando ci si alza da tavola), la struttura lo giustifica pienamente. Vino perfetto da bere mentre si aspettano i suoi fratelli di uno e quattro anni più giovani.
Per mera coincidenza, questa puntata della classifica esce nel giorno del compleanno di Stanko Radikon, che ha lasciato questa Terra nel 2016 ma vive e lotta insieme a noi, ricordato in questo giorno con una bellissima manifestazione nella sua terra a cui avrei voluto essere presente invece di rimanere affaccendato nelle mie faccende milanesi.
A Radikon il mondo del vino di oggi deve moltissimo. Cinque decenni (i primi quattro con il patriarca al timone, il nostro con il figlio Saša che ha raccolto un’eredità pesantissima) di riflessione, studio e osservazione di un territorio, che resta ma non è mai uguale nel tempo, e dei vitigni, le tecniche, i gusti, che cambiano sia di per sé sia in funzione del cambiamento del territorio.
Dalla prima macerazione sulla ribolla, datata 1995, sono passati quasi trent’anni, e se l’arancione è ormai definitivamente accolto come uno dei quattro colori del vino dobbiamo molto a quella svolta coraggiosa, sua e di Josko Gravner. Le macerazioni qui oggi durano mesi, sono arrivate le bottiglie da litro (non per scelta estetica o di marketing, ma per una migliore resa del tappo e del vino che c’è dentro) e la rinuncia totale ai solfiti.
E comunque, sto divagando. Singola parcella (individuata dal riferimento catastale) di ribolla, tre mesi di macerazione, quattro anni in botte e almeno dieci in bottiglia.
Come è giusto aspettarci, è un vino già pronto da bere, che esplode in una grande complessità, tra drupe gialle mature, miele, fiori in infusione, note balsamiche, minerali, addirittura di grafite, erbacee, laddove in bocca abbiamo una grande potenza e rotondità, ma soprattutto una profondità minerale rara in qualsiasi vino.
È difficile condurre macerazioni lunghe preservando tutte le sensazioni che riconducono al territorio, oltre che, cosa ancora più importante, la bevibilità e la piacevolezza del vino stesso; vini come questo hanno generato una schiera di imitatori che hanno conseguito risultati mediocri, e che fortunatamente sono spesso tornati almeno in parte sui propri passi ammettendo i propri peccati di superbia. Qui, però, siamo di fronte al maestro.
Questo è uno di quei 4-5 vini che cito abitualmente come “i Sassicaia del Terzo Millennio”: tagli bordolesi della costa toscana che cercano di recuperare la veracità, l’impatto, la personalità delle migliori annate di quello che è il loro predecessore più famoso, ma con un approccio non interventista in vigna e in cantina che è quello che rappresenta noi e l’era in cui viviamo.
Qui l’approccio non è esattamente lo stesso di Bolgheri, c’è parecchio syrah, c’è un 25-30% di raspi, c’è affinamento prima in tonneau e poi in cemento. C’è però un vino che “sassicaieggia”, marcato chiaramente dal cabernet, tra il ribes nero e il sottobosco, con una bella precisione e finezza. La struttura non gli manca, si allarga in bocca, pieno e carnoso, ma senza uscire dai binari. Una prova impressionante che ci mostra che c’è movimento anche in alcune zone colpevolmente spesso trascurate dai vinoveristi.
Aspettavo questo momento: il momento di premiare meritatamente un vino dell’Amiata tra i migliori d’Italia. L’Etna di Montalcino è ancora un territorio sconosciuto ai più – non ai vignaioli che hanno già acquistato a spron battuto e hanno già fatto uscire una pluralità di vini interessanti – ma è tra quelli con il maggior potenziale di crescita.
Giuditta Previtali, cugina di un grande brunellista come Marino Colleoni, interpreta magistralmente un’annata insidiosa nella sua vigna più vocata, piante di 50 anni su terreno roccioso e arido. Cupo, austero, profondo, non fosse per un affinamento chiaramente meno prolungato potrebbe passare per Brunello; il profilo è nobile, a tratti ritroso, il tannino vibrante, la lunghezza encomiabile. Un vino che può andare lontano, ma di cui per la totale assenza di storico -questa è appena la seconda annata- è difficile prevedere in modo puntuale l’evoluzione: faccio mio il suggerimento di Laurent Ponsot su quando bere il suo Clos de la Roche, “comprane 12 bottiglie e aprine una all’anno, se avrai fortuna ne avrai ancora diverse da bere quando sarà il suo momento”.
Restiamo nell’ambito della costa toscana, con un vino che interpreta il territorio di Bolgheri senza la minima velleità di reinventare il cucchiaio, ma semplicemente facendo le cose per bene. Ribes nero, erba tagliata, humus, una bocca piena, profonda, carnosa ma con la giusta freschezza, insomma un vino che ha tutto e rappresenta un modello esemplare per quella che, piaccia o no, è una delle denominazioni più prestigiose d’Italia.
Dopo uno stupefacente Carema 2020, grande era la curiosità per la riserva di questa piccola ma meravigliosa cantina che rappresenta una delle realtà più scintillanti del nord Piemonte. Se quello ci spiazzava totalmente facendo pensare addirittura a Chambolle-Musigny, qui ritorniamo a parlare solo la lingua del nebbiolo, ma lo facciamo con un eloquio che conquista. Agrumi, melagrana, erbe officinali, un profilo fresco che si concede più di quanto normalmente appare in zona, per un vino che mostra già un equilibrio sorprendente al palato pur mandando chiari segnali di poter avere decenni di favorevole invecchiamento davanti a sé. Una perla.
L’approfondimento dei chiantigiani (che siano dentro o fuori la denominazione, in questa sede, ci interessa davvero poco) è formazione continua, e i vini di Monteraponi rappresentano a pieno titolo dei nuovi classici della materia. L’azienda di Michele Braganti continua a interpretare in modo rigoroso e verace uno dei migliori territori per il sangiovese -ancor più in questi tempi in cui l’acidità è il nuovo oro- trovando una quadra tra la tradizione e la consapevolezza dei modelli stilistici nazionali e non.
Grande finezza, frutto croccante, bella florealità, una materia di partenza palesemente di grande livello considerando integrità e coesione dopo tre anni di botte grande, ha il respiro del vino importante che nasce ossigenato e mai ossidato, rimane fragrante e appena carnoso, di un equilibrio encomiabile. Parla la lingua dei grandi vini rimanendo saldamente nella terra che l’ha generato.
Non è un mistero che consideri questa azienda una di quelle di riferimento in Langa e la mano di Eleonora Barale una tra le più felici della nostra era. Quest’anno il cru che ho preferito è il Castellero, che anche in questo caso racconta l’AnnataStrana® mostrandosi aperto, con un frutto esuberante e aperture che vanno dalla rosa al sottobosco alle radici. Esplosivo ma preciso, succoso, con un tannino perfettamente coeso, di lunghezza addirittura insolita per il cru, costituisce una grande prova di cui sarà un piacere monitorare l’evoluzione: come già detto, la 2020 per il Barolo non assomiglia ad alcuna altra annata, per cui possiamo solo fare prudenti congetture sul suo invecchiamento, tuttavia i dati analitici, in particolare il pH, mi instradano su un nemmeno così cauto ottimismo.
Il classicismo del nord Piemonte se ce n’è uno. Un anno e mezzo in tonneau e altrettanto in botte grande. Azienda nota per il rigore dei suoi nebbioli, che hanno sempre bisogno di un po’ di tempo per esprimersi.
Qui l’austerità non manca di certo, in un profilo da manuale, di ciliegie e rosa in boccio, di cuoio e legno di cedro, di pepe bianco e lavanda essiccata. La bocca è coesa e vigorosa, il tannino è importante e imponente, il volume nel palato è davvero grande. Un vino che sa di tutto quello di cui deve sapere il nebbiolo per quelli che lo amano e l’hanno sempre amato, e che spesso guardano verso la provincia di Novara per ritrovare quei brividi che in Langa negli ultimi decenni sono sempre più rari. Nobiltà e ampiezza, suadente profondità e impareggiabile vocazione gastronomica. Gli si dia un po’ di tempo in bottiglia, però!
Le parti terza, quarta, quinta e le due classifiche bonus usciranno su questa newsletter quando avrò tempo.