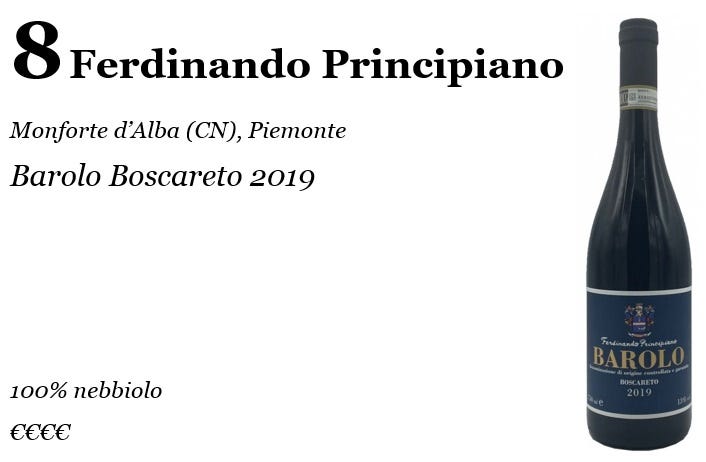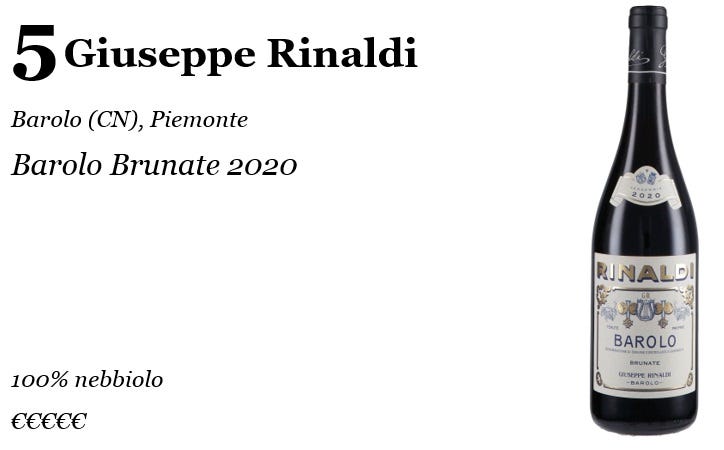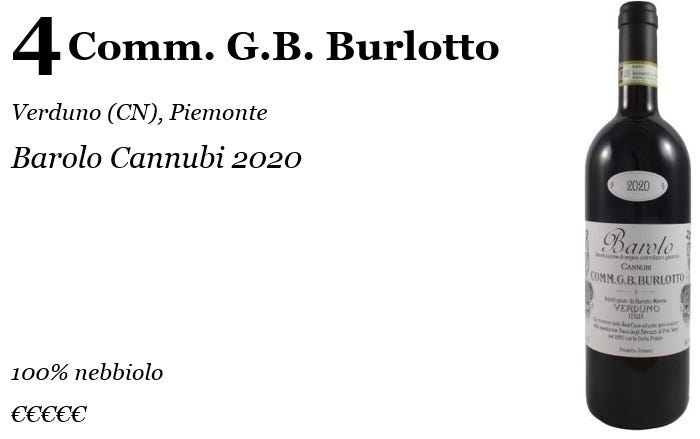Alla fine ci ho messo una settimana più di quanto sperassi, ma ce l’ho fatta a chiudere questo muro di testo con un pizzico di grafica. Visto che è già tardi, partiamo subito, dopo avere ricordato che le risposte alle domande frequenti sono nell’introduzione alla prima parte e che qui c’è LA NECESSARIA NOTA METODOLOGICA:
Non più di un vino per azienda; solo vini assaggiati in bottiglia per la prima volta durante il 2024; solo vini usciti durante il 2024; solo vini di cui non sia uscita un’annata successiva durante il 2024. I simboli dell’Euro (da uno a cinque) danno un’idea della fascia di prezzo.
E quindi, andiamo a vedere la top 10.
Un altro vino che è qui a testimoniarci come lo stato di salute della denominazione sia migliorato rispetto a qualche anno fa, e come i migliori manici abbiano ben tarato le maturazioni, gli appassimenti e i legni. In questo caso ci sono ben quattro anni in botte da 50 ettolitri e almeno un altro anno di bottiglia, ma la materia è perfettamente in grado di reggere tale affinamento.
Si tratta di una versione che certamente ha una potenza degna di nota, maturo, glicerico, intenso, estrattivo, ma il pugno d’acciaio resta delimitato in un guanto di velluto, tutta questa materia non è a scapito della precisione, della finezza o di acidità volatili fuori scala. Considerando quelle che sono le caratteristiche desiderabili in un Amarone, si tratta quindi di un successo su tutta la linea per quello che resta uno dei punti di riferimento in Valpolicella.
Da ormai più di un decennio, dobbiamo a Giovanna Maccario il recupero del cru Curli a Perinaldo, vigna che Veronelli definì “La Romanée-Conti italiana”, allora vinificato da Emilio Croesi, un nome che alla stragrande maggioranza dei lettori dirà zero. Ma non importa, perché oggi questa vigna dà vita a uno dei più straordinari vini italiani.
È un Rossese diverso da tutti gli altri, inclusi i cru -sempre con due piedi dell’eccellenza- della medesima azienda. Ha un passo a sé per l’eleganza, si concede ma non troppo, con un profilo un po’ mediterraneo ma in effetti anche un po’ borgognone, tra frutti di bosco ed erbe aromatiche, fiori appassiti e mineralità appena fumé. L’acidità vibrante ne evidenzia la giovinezza e suggerisce la capacità di invecchiamento, pur essendo il profilo già in armonico equilibrio. Risulta verticale nonostante la struttura tutt’altro che esile, facendoci tornare al concetto di “potenza senza peso” tanto caro a chi ama il vino di Borgogna.
Una bottiglia che, specie a concederle un po’ di tempo in cantina, ha piena dignità in qualsiasi contesto, e che probabilmente in campo internazionale rappresenta uno dei segreti meglio custoditi del vino italiano. Sono più di vent’anni che a modo mio promuovo i vini di Dolceacqua, e anno dopo anno sono sempre più felice di constatare i progressi non solo delle punte di diamante, ma dell’intero movimento locale.
Il produttore è un produttore del cuore, mentre avrei difficoltà a dire a quale sua vigna voglio più bene, compresa una da cui vinifica una delle pochissime Barbera d’Alba davvero grandi. Questo ad ogni modo è considerato il suo cru di maggior pregio, e a questo giro mi accodo.
Non più tardi di due sere fa ho aperto la 2016 di questo stesso cru, con qualche timore fosse troppo giovane, ma trovandola invece già pienamente espressiva oltre che – ma questo lo sapevo – di grande stoffa, perfetta definizione, paradigmatica classicità, leggiadria di altri tempi nel contesto dell’intensità che ci si aspetta da un vino di questa vigna. Tutto questo nonostante sia evidente mi trovassi davanti a un vino con almeno un quarto di secolo di evoluzione positiva davanti a sé.
Potrei ripetere molte cose, ma traslate indietro di tre anni, per l’annata corrente, il che implica che questo è un capolavoro in fasce. Materia stupenda, nobile, compatto ma al tempo stesso stratificato e cesellato, aperto ma non troppo e al contempo austero ma non troppo, maturo ma fragrante. Accade lo stesso in bocca, estrazione al punto, grande intensità ma inserita in un profilo di una grazia che in Langa semplicemente non esiste più. O quasi. Principiano è uno dei più grandi interpreti del Barolo dei nostri tempi e fortunatamente le persone di cui mi frega qualcosa non hanno difficoltà a riconoscerlo.
Quella di Riccardo Campinoti è la più costante nell’eccellenza fra le aziende che annoveriamo nella new wave di Montalcino, intendendo quei vignaioli che dopo il 2000 hanno creduto in un’idea di Brunello al tempo stesso classica, ben inserita nel solco della tradizione ma al tempo stesso al passo con i nostri tempi, con un’agronomia forte delle conoscenze del terzo millennio e un’enologia che può permettersi di essere poco interventista.
In annata perfetta, c’era da aspettarsi che il più blasonato fra i cru aziendali rubasse la scena, ma forse non che lo facesse a questi livelli. Mi ha totalmente stupefatto per l’eleganza e la precisione, al limite dell’irreale considerando la potenza e la struttura date da vigna e annata, per le quali soprattutto a questo stadio era lecito aspettarsi un monolite anche ai massimi livelli di vigna e manico. Un vino semplicemente memorabile, frutto di condizioni ideali in cui la mano esperta e la chiarezza di intenti del vignaiolo hanno fatto il resto.
La 2018 in Langa è stata correttamente inquadrata come un’annata minore, soprattutto alla luce di quello che sono la 2019 e la 2021; caratterizzata da notevoli difficoltà agronomiche, pur al netto di certosine selezioni delle uve anche i vini migliori non hanno la profondità e la complessità delle migliori versioni.
Cavallotto in questo caso fa eccezione, complice probabilmente anche il particolare microclima del Bricco Boschis (è facile accorgersene: arrivi in cantina e ci sono le palme). Non è certo un vino stretto né irrisolto, la maturità è quella giusta, nemmeno si tratta di una versione leggera o minore ma di una con tutta l’intensità che è lecito aspettarsi da un cru di questo lignaggio; niente da eccepire anche sul fronte dell’ampiezza aromatica, mostrando tutto lo spettro tipico del cru. La bocca poi è solare, ampia, carnosa, il tannino importante ma di eccellente fattura, la struttura sorretta da una vigorosa acidità che lo verticalizza. La chiusura sul tannino ci avverte che aprirlo ora sarebbe un peccato di gioventù, ma non ho trovato nulla che pregiudichi un’evoluzione totalmente positiva, il profilo è coeso, paradigmatico, di perfetta ampiezza.
Assaggiato più volte nel corso dell’ultimo anno, si sta ancora assestando in bottiglia e migliora nettamente dopo ore dall’apertura; richiede pazienza, ma è in grado di premiarla lautamente.
Chi mi conosce appena un po’ non poteva non aspettarsi la presenza di Rinaldi ai piani alti della classifica; non faccio mistero di considerare Marta Rinaldi il miglior manico italiano vivente, e se mancasse questo vino (o più raramente il Tre Tine, o potenzialmente il Bussia, che è solo alla seconda vendemmia ma dà già luogo a grandi versioni ai vertici delle interpretazioni del cru) significherebbe che o è successo qualcosa a lei, o è successo qualcosa a me. Il Barolo di Rinaldi, oggi, è uno dei pochissimi vini italiani che si possono acquistare sempre a scatola chiusa, e il merito va alla nuova generazione: amo e ho sempre amato i vini del Citrico (Beppe Rinaldi, il padre, che ci ha lasciati alla vigilia della vendemmia 2018), ma la costanza e l’affidabilità non sono mai stati le loro qualità migliori.
In una versione comunque importante, ma meno monolitica della 2019, si identifica immediatamente come un vino di Rinaldi; in questo Rinaldi e Roagna stanno diventando come DRC e Leroy, in quanto le loro interpretazioni del territorio sono sempre personali e riconoscibili. La finezza lo pone in una categoria a sé, il profilo è classico ma classico dei tempi andati, di quegli anni 70/80 in cui il Barolo era un vino di luce, ampio, fine, floreale, agrumato, il frutto dolce e appena acidulo, la spezia fragrante e non scura, la cipria, il cuoio e una nota balsamica (un tono e mezzo sotto il Bussia che si riconosce da questo).
Nella freschezza -non scontata in un’annata più calda della media- e nell’eleganza assoluta, si pone come un nuovo paradigma di risoluzione a questo stadio evolutivo; storicamente i vini di Rinaldi non erano MAI pronti alla fine del quarto anno dopo la vendemmia, anzi erano abitualmente più indietro degli altri per poi sorpassarli con calma olimpica. Una combinazione di mano e mutate condizioni climatiche ha cambiato le carte in tavola; è comunque un vino che ha l’intensità che si addice a uno dei migliori Barolo sulla piazza, ma si distingue per leggiadria e straordinaria bevibilità, il tannino pur esce ed è nelle medesime proporzioni della 2019 stante la minore estrazione, l’acidità non è certo da annata “troppo calda” come è stata bollata troppo in fretta la 2020. Calda sì, ma un manico di trascendentale abilità, con vigne di eccellenza assoluta a disposizione, ha saputo tirarne fuori questo.
Uno dei temi del barolismo dell’ultimo decennio è stato l’inarrestabile ascesa di Fabio Alessandria da buon interprete (facilmente reperibile a ottimi prezzi) a mostro sacro categorizzabile alla voce “il meglio del meglio” (con le logiche conseguenze di reperibilità e prezzi). Tutto assolutamente meritato, a mio parere a partire più o meno dal 2013 qui si è innestata progressivamente un’altra marcia che ha prodotto interpretazioni tra le migliori in assoluto nel comune di Barolo, e le migliori senza tentennamenti in quello di Verduno, che ha conosciuto i riflettori della critica e del mercato dopo una vita passata ad essere considerato un comune di serie B.
La discussione su quale sia il migliore fra i tre cru di punta aziendali è sempre aperta, e produce, di anno in anno, risultati differenti. Per l’Annata Diversa da Tutte le Altre® una grandinata ci ha portato via l’Acclivi, e tra Monvigliero e Cannubi anche confrontandomi con altri palati esperti e allenati ho riscontrato una convergenza verso il secondo, ancora più integrato e coeso nelle sue componenti, concentrato ma austero.
Il profilo è splendido, quello di un Barolo d’altri tempi, ma al tempo stesso totalmente Burlotto, ciliegie scure e spezie, grande mineralità e balsamicità, austero e preciso. La bocca si allarga in un profilo di grandissima intensità, ben sorretto, il tannino ruggisce, è importante come quantità ma di straordinaria fattura, l’alcool c’è ma è parimenti integrato alla perfezione in un quadro complessivo di strepitosa, vibrante profondità, verticale il giusto, il legno in via di digestione senza disturbare il profilo. Un vino cesellato, paradigmatico, che in questo caso ha eleganza, potenza E peso. La materia è grande, e richiederà del tempo per distendersi, ma meno che nel 2016 o nel 2019. Quindi, per godere appieno di questo grandissimo Barolo servirà un po’ di tempo, ma non così tanto, al netto del suo essere meno pronto di altri 2020.
Uno dei più elusivi e mitologici vini di Langa, nato da una scommessa di Teobaldo Cappellano che al tempo, una quarantina di anni fa, suonava come follia: impiantare qualche filare non innestato di nebbiolo Michet (antico clone con grappoli spargoli, fragile ma di grande qualità; anche il Ca’ d’Morissio di Mascarello è tutto Michet) nel cru Gabutti a Serralunga d’Alba.
Poche bottiglie, care, e tremendamente difficili da reperire in Italia e in Europa, visto che abbiamo passato decenni a inseguire modelli del cazzo ignorando i nostri veri campioni e oggi il grosso dei vini di Cappellano prende la via degli Stati Uniti, dove è più facile berli che in Italia. Inoltre saranno poco meno di 15 anni che non vedo Augusto, figlio di Teobaldo che ci ha lasciati nel 2009, al tavolo di una fiera. Si aggiunga lo storico disinteresse dell’azienda per la critica e le guide e la conclusione è che non ci sono grosse scorciatoie per assaggiare questo vino: servono passione, motivazione e disponibilità a sostenere un certo sforzo.
Il risultato, però, è un vino monumentale e di straordinaria personalità. Ha il profilo dei grandi nobili di Serralunga, luce fredda, energia e tensione, agrumi, fiori e tante erbe aromatiche, di una precisione incredibile, solo muscoli scolpiti come marmo di Carrara senza un filo di grasso, il bicchiere come il palco del Mr. Olympia. Un vino senza tempo che fa battere il cuore riportandoci ai fasti di quei Barolo di Serralunga che ci lamentiamo non esistono più, in primis gli anni Settanta e Ottanta di Bruno Giacosa. Ma questo è fatto oggi, e indubbiamente il clone e la vigna a piede franco danno una maggiore profondità ed espressività a questo paradigma assoluto del classicismo di Langa.
Uno dei Barolo di riferimento, frutto forse della più leggendaria delle vigne di Langa, la parcella di Vigna Rionda che fu di Tommaso Canale, vinificata tra il 1967 e il 1993 da Bruno Giacosa, poi per un breve periodo da Roagna e ora confluita tra i possedimenti di Giovanni Rosso, che convenientemente è diventato un manico tra i più sapienti nell’interpretare il vino di Langa attraverso gli ostacoli sempre diversi che la natura sa tirarti nella schiena.
In questo caso, abbiamo una vigna in grado di trascendere l’annata e un manico che non ha commesso errori. Alcuni, non molti, nebbioli 2020 hanno preso un profilo di straordinaria, elegante apertura nel segno della freschezza più che della maturità, con note floreali e di fruttini rossi che fanno pensare a tratti più alla Borgogna che al Piemonte. Questo è solo parzialmente il caso, perché la finezza è di un Musigny o di un Clos Vougeot, ma c’è anche un’austerità tutta piemontese, in un profilo comunque che è quello, fiori secchi e macerati, ciliegia rossa e lampone, tanta spezia. In bocca è leggiadro ma fermo, il tannino importante ma vellutato, l’alcool perfettamente bilanciato, la materia integrata con sapiente maestria. Un grande Vigna Rionda, di rara stoffa, espressione innanzitutto del cru e con ogni probabilità destinato a grandi cose anche nel medio, oltre che nel lungo termine.
E così arriviamo a incoronare il miglior vino italiano uscito nel 2024, e si tratta senza dubbio di uno dei numi tutelari della nostra enologia, in un’annata che a Montalcino è grande, grandiosa, ma anche nella prima vendemmia che segue la morte di Gianfranco Soldera.
Su questo fatto ho letto speculazioni di ogni genere, ma la realtà dei fatti è che Soldera, nato imprenditore e diventato vignaiolo già adulto venendo dalla città, ha gestito la sua azienda agricola come qualsiasi imprenditore illuminato gestirebbe un’azienda, ossia anche assicurandosi che questa sopravvivesse al suo fondatore. Tutto l’enorme know-how agronomico, enologico, geologico, meteorologico, biologico e microbiologico che è capitale immateriale di Case Basse è rimasto intatto, e con esso le procedure aziendali: sapendo questo, c’è veramente da stupirsi che qui si continui a fare grandi vini?
Semmai, c’è da disquisire sul quanto grandi: orbene, questo 2019 ha la stoffa dei grandissimi, è un monolite che rimanda alla grande Riserva 1999, quando era ancora Brunello, prima che Soldera decidesse di uscire dalla denominazione.
La doverosa premessa è che non c’è NESSUN motivo per bere questo vino ora: non solo è a uno stadio embrionale della sua evoluzione, ma dà anche segno di iniziare una fase di chiusura che, con ogni probabilità, dovrebbe durare per qualche anno, prima che ricominci a distendersi. Il sacrificio (anche economico) che ho fatto per assaggiarlo, per capire quale fosse lo stato dell’arte di uno dei miei vini del cuore e di uno dei punti fermi dell’Italia del vino, è un sacrificio che sconsiglio, considerando anche la scarsa reperibilità del vino in questione. Compratelo, compratelo assolutamente se è nel vostro budget, ma tenetelo in cantina.
Ciò detto, questo è un Brunello (è tecnicamente fuori dalla denominazione, ma è un Brunello) semplicemente straordinario. Il naso inizia a dare i primi segni di chiusura ma, dandogli tempo, si rivela esuberante, stratificato, sfaccettato, un pot-pourri di deliziosa florealità poi le ciliegie, le spezie, la grafite, in un profilo che è tutto bellezza, senza calcare sull’impatto ma che comunque finisce per essere ipnotico. La definizione, la purezza, la fragranza sono a fondo scala. Ha quell’equilibrio zen, quella grandezza assoluta senza eccessi che è difficile descrivere, che generalmente si associa a uno e un solo vino: Romanée-Conti. E con questo credo di avere detto tutto, vostro onore. Mic drop.