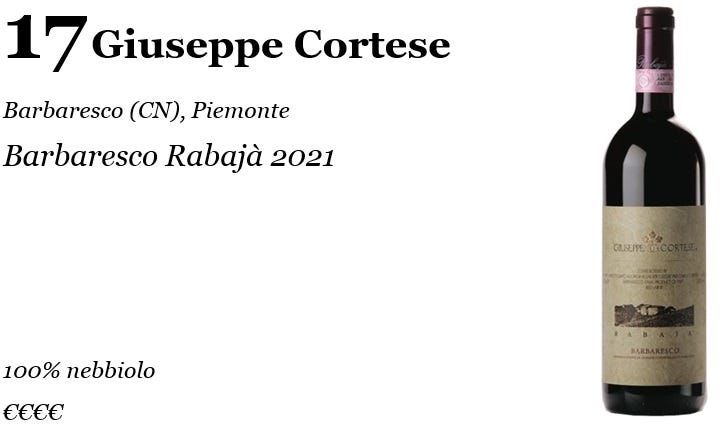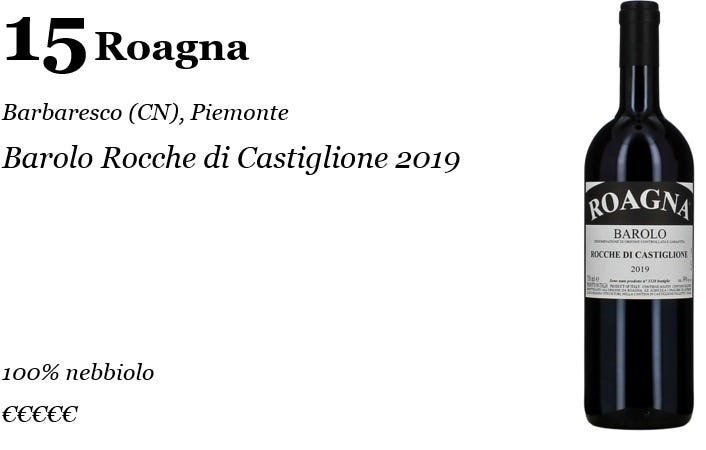Eccoci qui, sopravvissuti a tutti i Gran Premi della Montagna delle feste, intanto buon anno, spero abbiate mangiato e bevuto bene e in buona compagnia.
Da parte mia, inizio il 2025 rispettando un buon proposito per il suddetto, ossia cercare di pubblicare con buona frequenza rispettando le scadenze che mi sono dato da solo. Questo post sarebbe dovuto uscire, ambiziosamente, il 2 gennaio, e il 2 gennaio esce.
Come al solito, ricordo che le risposte alle domande frequenti sono nell’introduzione alla prima parte, mentre ripubblico LA NECESSARIA NOTA METODOLOGICA:
Non più di un vino per azienda; solo vini assaggiati in bottiglia per la prima volta durante il 2024; solo vini usciti durante il 2024; solo vini di cui non sia uscita un’annata successiva durante il 2024. I simboli dell’Euro (da uno a cinque) danno un’idea della fascia di prezzo.
Ritmo quindi, ritmo, e procediamo con la posizione numero
L’idea è un’idea semplice: l’aglianico di Taurasi (le vigne sono a Montemarano e Castelfranci, i due cru più nobili della denominazione) quando non gli fai niente. Né chimica in vigna, né legno, né filtrazioni, chiarifiche eccetera eccetera. Giusto un po’ di solforosa dopo un affinamento in anfora. Ma soprattutto rese che strizzano l’occhio alla Borgogna più che alla Campania.
Un’azienda che ho visto nascere da zero, anzi da meno uno, dato che la mia conoscenza e amicizia con il proprietario risale ad anni prima della fondazione dell’azienda stessa.
Un vino di cui ho vissuto tutte le incarnazioni e le peripezie, da quando era vinificato sull’Etna a quando era vinificato ancora sull’Etna ma da un’altra parte, poi a Milano e finalmente a una distanza ragionevole dalla terra che l’ha creato. E ora è giunto alla sua incarnazione successiva, a uno stadio evolutivo mai toccato prima, frutto di una consapevolezza e di un’esperienza che vengono dal progresso, dallo studio e dal tempo del vino, che normalmente si misura non in anni, ma in generazioni. Avrete quindi capito che questa è la migliore espressione di Ognostro finora e una delle massime espressioni dell’aglianico di ogni tempo. Non solo un grande vino, ma anche la fonte di numerosi spunti di riflessione, come il fatto che il territorio da cui proviene sia lo sleeping giant dell’enologia italiana.
Sono stato indeciso fino all’ultimo se inserire in classifica questo vino o l’altro Barolo a denominazione comunale della stessa azienda, quello del Comune di Castiglione Falletto, nella medesima annata. Alla fine per una questione di sfumature – questo è più ampio, e in questo momento più armonico – ho scelto, tra i due, il vino di più difficile reperibilità, dato che viene prodotto in quantità molto inferiori.
Mi preme tuttavia sottolineare come per Mario Fontana, tra i manici più irriducibilmente tradizionalisti che abbiamo in Langa, l’annata 2019 debba passare agli atti come “memorabile”, tra le migliori di sempre, con tutti e tre i Barolo prodotti – incluso quindi quello generico, che ha un rapporto qualità/prezzo encomiabile – al vertice assoluto della rispettiva categoria.
Parliamo dunque di un Barolo che più classico non si può, di rara eleganza, che punta più sulla bellezza che sull’impatto, già in equilibrio, ricco, fragrante, complesso e persistente. Ovviamente il tannino è quello dei 2019 e l’optimum di bevibilità va spostato di qualche anno in avanti, ma è difficile definirlo già ora men che delizioso, e un fenomeno assoluto in prospettiva.
La vicenda di Davide Bentivegna è una vicenda erratica, un percorso ormai più che decennale in cui, anche attraverso errori (soprattutto organizzativi e commerciali, raramente enologici, mai agronomici), è arrivato a raggiungere apici qualitativi che lo pongono come punto di riferimento dell’Etna, forse dietro al solo Frank Cornelissen, il cui cammino dell’eroe è per certi versi simile anche se con altra visione e altri mezzi a disposizione.
Bentivegna ha un talento quasi mistico nel guardare una vigna e pensare al vino che ne potrà trarre, una comprensione dei versanti, delle contrade, dei singoli filari che non si riterrebbe possibile con un’esperienza di poco più di una decina di vendemmie; eppure così è. Ovviamente il prezzo di questa capacità è una linea commerciale che fluttua, di anno in anno a seconda di quello che la natura concede, per cui è necessario guardare i dettagli per conoscere la genesi di ogni vino, con la consapevolezza che l’anno seguente le condizioni e le scelte potrebbero essere diverse.
Quest’anno il vertice della produzione aziendale, e al tempo stesso il miglior Etna di nuova uscita che abbia assaggiato, è frutto delle sole vigne a piede franco di Linguaglossa, in contrada Galfina, versante nordest quindi, fra i 650 e i 730 metri di altitudine. Sono alberelli di una settantina d’anni con la promiscuità che è normale attendersi da una vigna storica. La macerazione è piuttosto breve (12 giorni), poi un anno in barrique usate.
Il risultato è un mezzo capolavoro. Uno di quegli Etna che – al netto di una mediterraneità riconoscibile, nei giorni buoni, a un degustatore attento - nebbioleggiano, austero e finissimo, di grande definizione, nitido, profondo, tannico il giusto, già di grande complessità. Serio e radioso al tempo stesso. Già grande oggi, meglio domani.
Azienda che è diventata negli anni sinonimo della tradizione di Barbaresco, cru che immediatamente viene associato a questo produttore quando si pensa al suo migliore esempio.
In annata di grazia, non ci aspettavamo niente di meno di una quintessenziale espressione del cru. Un vino che ho assaggiato molte volte negli ultimi mesi in cui si è progressivamente aperto, molto floreale, con un bel frutto, note speziate e balsamiche che lo arricchiscono; già aperto, mostra i muscoli con un profilo potente e generoso, il tannino importante ma di perfetta trama e definizione. È ancora chiaramente indietro nella sua evoluzione, ma la stoffa è innegabilmente quella del fuoriclasse.
Azienda e vino di cui ho ampiamente parlato su queste pagine; l’uscita della nuova annata, peraltro di più difficile gestione agronomica rispetto alla precedente, non fa che confermare quanto di bene affermato in passato.
Espressione di sangiovese unica e di forte personalità, con l’accento sul frutto, sulla piacevolezza, sull’immediatezza, ma con la parte minerale, anzi salata, che ribadisce il territorio. Per gli amanti della nuova Borgogna e per chi avesse ancora qualche dubbio sulle potenzialità del sangiovese in Romagna riguardo la produzione di vini di qualità assoluta.
Quest’anno, con mio sommo dispiacere, non sono riuscito ad assaggiare l’intera gamma dei 2019 di Luca Roagna, ormai consacrato da tempo nell’Olimpo dei più grandi vignaioli del mondo, ma tra quello su cui sono riuscito a mettere le mani, o meglio i bicchieri, ci sono senz’altro esempi di magnificenza assoluta.
Questo cru è l’ultimo arrivato nel portafoglio aziendale – la prima annata prodotta è stata la 2016 – ma la parcella di mezzo ettaro acquisita è all’altezza del blasone aziendale, e manico e annata hanno fatto il resto.
Un Barolo dal naso incantevole, a tratti borgogneggiante, qualcuno dirà Madame Leroy, tutto finezza, già complesso, di precisione chirurgica, con una gran materia ma condotto in totale eleganza e sensualità, tannino carezzevole come vigogna e in quest’annata e a questo stadio non era facile. Ovviamente in divenire, ma ovviamente strepitoso.
Cominciamo a mettere i puntini sulle i. Non ho la minima simpatia per Angelo Gaja, un uomo il cui paragone con il dio Zeus trovo calzante: con grandi mezzi a disposizione, entrambi hanno creato grandi cose e fatto grandi danni, in nome del proprio egocentrismo.
Sarebbe da folli non riconoscere che il successo dei vini di Langa e in particolare di quelli di Barbaresco debbano moltissimo ad Angelo Gaja (e molto anche a un altro personaggio controverso come Marc De Grazia), così come sarebbe da folli dire che Costa Russi 1978 o Sorì Tildin 1982 non siano vini assoluti.
Ma Gaja significa anche barrique tostate, rotomaceratori, uscire dalla denominazione (ufficialmente) per tagliare il Barbaresco con la Barbera, spiantare il nebbiolo per mettere il Cabernet (Darmagi), eccetera eccetera. Gaja piace alla gente che mi sta sul cazzo, e fino a non molto tempo fa citavo l’annata 2001 di questo cru come il suo ultimo grande vino.
Però solo l’ideologia o la voglia di non farmi dei nemici tra i miei lettori mi permetterebbero di negare che negli ultimi anni qualcosa sia cambiato, al netto del fatto che parliamo di un’azienda che ufficialmente produce circa 350.000 bottiglie l’anno in agricoltura convenzionale, ossia di industria, quell’industria che detesto ed ergo a mio nemico.
Tuttavia l’onestà intellettuale mi impone di dire che questo è un grande vino e un grande Barbaresco. Potrei sapere qualcosa che preferisco non scrivere, ma tutto quello che sto scrivendo è vero ed è qualcosa di cui sono convinto.
Insomma, senza girarci troppo intorno questo, lo ripeto nel caso fosse sfuggito, è un grande vino e un grande Barbaresco. Non va troppo per il sottile e quasi stordisce per l’impatto, per la potenza aromatica, in un profilo assai floreale ma anche molto speziato, con ulteriori note più scure che lo arricchiscono di complessità, delineando un quadro la cui messa a fuoco non è mai in discussione. La materia è davvero grande e importante, è profondo e minerale, il tannino fitto ma mai disturbante, c’è giovinezza, ma indubbiamente c’è anche integrazione. Costa un botto, rappresenta una quantità di cose che non mi piacciono, ma cosa gli vuoi dire?
La doverosa premessa è che i Nero d’Avola di questa azienda rappresentano la misura aurea dell’espressione del vitigno in quello che è il suo territorio di elezione, ma, detto che l’azienda stessa rappresenta da un punto di vista sia ideologico sia materiale la quintessenza di quello che dovrebbe essere la produzione di vino ai giorni nostri, questa bottiglia mi ha causato un tale shock, una tale epifania, una tale sindrome di Stendahl che sapevo ne avrei dovuto parlare.
Su come viene fatto questo vino, prendo in prestito un disegnino dal sito aziendale, rielaborato omettendo i dettagli relativi a un’altra etichetta:
(giusto due numeri: il vino ha passato TRE ANNI in barrique di gelso e UN ANNO in damigiana esposta al sole. E non so se avete contezza di quanto picchi il sole alla latitudine di Noto. Io sì, essendoci anche stato di recente e avendo visto quelle stesse damigiane)
Ovviamente, nonostante la grande stima verso il vignaiolo, mi aspettavo una botta di volatile non indifferente. Il primo shock è stato quindi constatare quanto limitata fosse la componente acetica. Il naso è bizzarro, combinando ossidazione nobile e profilo tipico da uva aromatica, assieme a note da vino dolce evoluto.
In bocca un altro shock. Il profilo ossidativo si ritrae, abbiamo davanti un vino fresco, fragrante, le note sono di frutta matura, stramatura, disidratata, ma ribadisco non ossidato, a patto di non avere un totale rifiuto dei vini secchi da uva aromatica non si può non rimanerne rapiti, arriva una splendida parte floreale, è così verticale da poter essere definito tagliente, la beva è irreale considerando tutto quello che ci siamo detti.
Un vino assurdo. Un vino grande.
Dopo tanta grenache dalla Sardegna, ne arriva una dalla mia regione natale, con un vino famigerato per la scarsa reperibilità, per il prezzo importante, e perché l’altra e più famosa etichetta aziendale, Kurni, è notoriamente divisiva al punto di aver visto volare insulti e minacce discutendone.
Non si sviluppa come la bomba di frutto che ci si potrebbe aspettare, ma ha un profilo più complesso e stratificato, in questa versione con note soverchianti di macchia mediterranea, rosmarino bruciato, incenso, iodio, a contornare ciliegie rosse e nere. La bocca è ricca ma non enorme, l’equilibrio fra struttura, acidità e tannino lo rende un vino che non dico vada a flirtare con la perfezione, ma certamente rappresenta uno dei vertici mondiali di quest’uva. Magari da tenere ancora un po’ in cantina, ma non per forza per chissà quanto tempo.
Azienda di Lamole – chiaramente con Radda il mio terroir preferito nel Chianti – che lavorava bene anche dieci anni fa, ma che ha progressivamente alzato l’asticella. Questa Gran Selezione viene presentata come il frutto di vigne di 150 -centocinquanta- anni a piede franco. È un’affermazione che è ai limiti della verosimiglianza in quanto siamo sui massimi concepibili di longevità della specie Vitis vinifera ai giorni nostri, ma accetto di crederci, perché in questa bottiglia c’è qualcosa che non c’è in nessun altro vino del Chianti.
(Nota a margine: oggi parlare di una vigna di 150 anni è come parlare di un essere umano di 120, ma sappiamo da fonti certe che prima della fillossera esistevano viti di 500 anni in produzione. Del resto, oggi a Tramonti e in Occitania ci sono vigne ancora più vecchie)
La tipica eleganza di Lamole ci avvolge in un abbraccio di giaggioli, cipria, frutti di bosco, poi arrivano note più complesse e virili. In bocca ci ritroviamo un vino profondo e preciso, potenza quasi senza peso, come un Borgogna muscolare, un filo di austerità, grande pulizia, tannino perfettamente integrato, finezza indicibile, agrume e sale in chiusura. Memorabile.
La quinta e ultima parte, preceduta dalle due classifiche bonus, uscirà su questa newsletter quando avrò tempo.